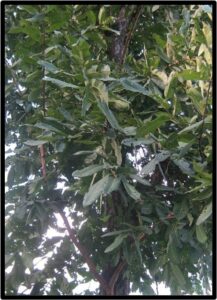Il Frassino maggiore è un albero classificato per la prima volta nel 1753 da Linneo, noto come Frassino comune o con il nome scientifico “Fraxinus excelsior“. La sua famiglia di appartenenza, le Oleaceae, è la stessa di Ulivi, dei Ligustri e dei Gelsomini. Questa specie è originaria di un ampio areale che si estende dall’Europa all’Asia minore, fino a raggiungere le regioni dell’Iran.

Il Frassino (Fraxinus excelsior) è una pianta amante della luce e dell’umidità, e per questo si trova con facilità nei boschi mesofili, nelle faggete rade e nei terreni di fondovalle. In Italia è diffuso praticamente in tutta la penisola, ma si incontra più spesso nelle zone collinari e montane del centro-nord. Le zone fitoclimatiche ideali per la sua crescita sono quelle del Castanetum, del Fagetum e, più raramente, del Lauretum. Richiede terreni profondi, ricchi di sostanza organica, e tollera anche la presenza di acqua stagnante. È inoltre capace di rigenerarsi spontaneamente in ex-coltivi abbandonati, dimostrando un’elevata adattabilità ecologica.
Questa pianta raggiunge dimensioni notevoli, con altezze che possono toccare i 40 metri. Il tronco è diritto, slanciato e cilindrico, spesso libero da rami fino a diversi metri dal suolo, qualità che lo rende particolarmente apprezzato in arboricoltura. La chioma è ampia, elegante, con rami ascendenti e leggermente arcuati, che conferiscono all’albero un aspetto maestoso.
Il Frassino (Fraxinus excelsior) è una pianta caduca, dotata di foglie imparipennate composte da 9 a 15 foglioline opposte, con margini finemente seghettati. La pagina superiore delle foglie è verde scuro e lucida, quella inferiore è più chiara. In primavera, prima della comparsa delle foglie, sbocciano piccoli fiori verdastri, privi di calice e corolla. I frutti, chiamati samare, sono allungati, con un’ala sottile che favorisce la dispersione tramite il vento. La corteccia, inizialmente liscia e di colore olivastro, col tempo diventa grigio-bruna e si fessura longitudinalmente. Le gemme, di colore nero e vellutate, sono una caratteristica distintiva della specie.
Il legno di Frassino è apprezzato per la sua elasticità, resistenza e leggerezza. Ha un colore chiaro, biancastro, con alburno e durame poco differenziati. Gli anelli annuali sono ben visibili e i vasi sono particolarmente grandi nella zona primaverile, il che conferisce una struttura porosa al legno. La fibra è solitamente diritta e regolare, rendendolo facilmente lavorabile.
Grazie alle sue proprietà meccaniche, il legno di Frassino è stato utilizzato per secoli in numerosi campi. È impiegato nella produzione di mobili, pavimenti, compensati e attrezzi agricoli, ma trova anche spazio nella realizzazione di strumenti musicali, timoni di barche e articoli sportivi come gli sci. Un tempo era il materiale preferito per fabbricare lance, giavellotti e ruote da carro, rendendolo un alleato insostituibile della tecnologia bellica e del trasporto dell’antichità.
Il legno fresco ha un peso specifico di circa 960 kg/m³, che scende a 720 kg/m³ da stagionato e a circa 660 kg/m³ da secco. Questo valore lo colloca tra i legni mediamente pesanti, con un buon potere calorifico, rendendolo adatto anche come combustibile.
La manna di Frassino (Fraxinus excelsior), una sostanza zuccherina che fuoriesce da incisioni nella corteccia, è stata storicamente utilizzata come blando lassativo, dolcificante naturale e rimedio contro la tosse. In passato, questa pianta era sacra presso molte popolazioni europee, e il suo legno era considerato un dono degli dei. Nell’antica mitologia norrena, l’Yggdrasill, l’albero cosmico che collega i nove mondi, era un frassino.
Il Frassino maggiore non è attualmente classificato come specie a rischio, ma soffre gli attacchi di numerosi parassiti animali e fungini, tra cui il temuto fungo Hymenoscyphus fraxineus, responsabile della “moria del frassino” in Europa. Una corretta gestione forestale e la prevenzione fitosanitaria sono essenziali per garantirne la sopravvivenza. La sua capacità di rigenerarsi naturalmente, soprattutto nei boschi radi e negli ambienti antropizzati, lascia comunque spazio all’ottimismo per il futuro di questa maestosa pianta.
Se vuoi conoscere altre specie di albero: visita l’Enciclopedia del Legno di Brini Legnami qui.